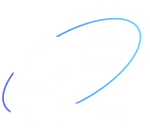Sono molti gli aspetti che fanno del Museo di San Marco a Firenze un luogo davvero unico nel suo genere. Nato come convento, venne in parte secolarizzato nella seconda metà dell’Ottocento, quando fu decretato monumento di importanza nazionale.
Al suo interno è conservata oggi la più grande collezione delle opere del Beato Angelico, artista-frate che qui visse e operò a lungo realizzando un imponente ciclo di affreschi. Tra questi, l’Annunciazione – tema ricorrente nella sua pittura – incanta gli spettatori con la sua imponente e raffinata sobrietà: un vero capolavoro del primo Rinascimento.
L’Annunciazione “in cima alla scala”: iconografia e stile
Già visibile fin dagli ultimi gradini che conducono al primo piano dell’ex convento, l’Annunciazione – detta “in cima alla scala” per distinguerla dalle altre dello stesso autore qui presenti – accoglie il visitatore e lo investe della sua grazia essenziale eppure maestosa. L’opera, realizzata intorno al 1440, si sviluppa per oltre tre metri di larghezza e più di due di altezza.
L’affresco raffigura l’Arcangelo Gabriele inginocchiato mentre preannuncia la nascita di Cristo alla Madonna; lei lo accoglie seduta su un semplice sgabello. Incorniciati da un austero loggiato, hanno entrambi le braccia incrociate sul petto, in segno di sottomissione alla volontà divina.
L’episodio appare però leggermente spostato verso destra. Questo curioso decentramento non è casuale, ma serve a esaltare la purezza di Maria. Il lato sinistro è occupato in buona parte da un prato fiorito protetto da una staccionata (simbolo della sua verginità), che si affaccia su un boschetto di cipressi. Anche i due tipi di capitelli che completano le colonne del loggiato alludono alle virtù della Vergine: quelli corinzi alla gloria, gli ionici all’umiltà.
Gli elementi decorativi sono ridotti al minimo: spiccano solo le variopinte ali dell’Angelo e i motivi dorati che ne ornano la veste, mentre Maria è sobriamente abbigliata. Sappiamo però che Beato Angelico usò la preziosa azzurrite per il manto della Vergine e inserti d’oro per le aureole, oggi purtroppo non più apprezzabili.
Due iscrizioni latine si dipanano lungo il lato inferiore del dipinto: la prima recita le parole di saluto dell’Angelo; “Salve o Madre della pietà e nobile abitazione della Santa Trinità” mentre la seconda è un invito rivolto agli astanti: “Quando entrando passerai davanti alla figura della Vergine intatta, stai attento a non dimenticare di dire l’Ave Maria”.
Sei interessato ad articoli come questo?
Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti e approfondimenti di BeCulture!
Tra Gotico e Rinascimento: tradizione e novità
L’Annunciazione è una delle opere più significative della produzione di Beato Angelico, anello di congiunzione ideale tra la fine del Gotico internazionale e gli esordi del Rinascimento.
L’angelo e la Vergine, infatti, conservano ancora tracce dell’iconografia medievale: nella monumentalità delle loro figure, statiche e isolate, nel panneggio e nella linearità delle vesti. Eppure, allo stesso tempo, si vedono già i segni della nuova cultura fiorentina, quella di Donatello, Masaccio, Michelozzo e Brunelleschi. I corpi di un’armoniosa plasticità, la geometria regolare del contesto architettonico raffigurato in prospettiva, la complessiva tridimensionalità della scena: tutto dichiara l’attenzione del pittore alle novità della sua epoca.
E poi ci sono le qualità proprie dell’Angelico, che conferisce all’Annunciazione una semplicità inedita, inserendo l’episodio sacro in un’atmosfera di assoluta quiete. Nulla turba la scena, immortalata nel suo momento più alto e intenso.
Un’intensità accentuata dall’ambientazione spoglia e dalla luce diffusa, assoluta, che contribuisce allo straordinario equilibrio estetico del dipinto: nell’Angelico, la bellezza della composizione diventa strumento per esprimere in modo ancora più chiaro e nitido la verità spirituale rappresentata.
Beato Angelico a San Marco
Poche sono le fonti documentali sulla vita e le opere di Guido di Pietro, detto Frate Giovanni de’ Frati di San Domenico da Fiesole e noto a tutti, oggi, come Beato Angelico (fu beatificato nel 1994, ma definito “Angelico” già dai suoi contemporanei). È dunque difficile datare con precisione il suo lavoro, compreso quello al convento di San Marco, che si suppone sia stato svolto tra il 1436 e il 1445, con qualche possibile intervento successivo.
Altrettanto aperta è la questione dell’attribuzione: quanti dei numerosi affreschi che decorano le lunette del chiostro, i corridoi e le celle sono stati realizzati unicamente dal maestro e quali, invece, dai suoi aiutanti? I pareri degli studiosi sono discordanti, sebbene sia unanime il giudizio sull’autografia dell’Annunciazione del corridoio orientale.
Sconosciuto è anche l’ordine di esecuzione dei vari dipinti, che potrebbero essere stati ritoccati dall’Angelico al suo rientro da Roma; né sappiamo quale fosse il programma teologico alla base degli affreschi delle celle. Le decorazioni, infatti, non seguono uno sviluppo consequenziale rispetto ai temi sacri descritti, né hanno tutte il medesimo soggetto: anche in questo caso sono state avanzate diverse ipotesi, senza alcuna certezza. Ciò che sappiamo, però, è che erano destinate ai frati dell’ordine domenicano, confratelli dell’artista, e che – probabilmente per questo – hanno un’impostazione ancora più essenziale dell’Annunciazione sopra la scala.
L’Annunciazione della cella 3 e l’evoluzione iconografica dell’artista
Oltre a quella in cima alla scala, il Museo di San Marco custodisce anche una seconda Annunciazione affrescata, nella cella 3 del corridoio dei chierici.
Pensata per una contemplazione privata, riduce al massimo gli elementi figurativi: disadorno ed etereo, il porticato è disegnato da una doppia campata di archi. L’angelo non appare più chinato ma ritto e l’esile Maria è inginocchiata su un umile panchetto da preghiera. A sinistra, San Pietro martire in preghiera. I personaggi sono leggeri, quasi incorporei, lo sfondo scarno e rarefatto; il trattamento della luce e i colori, con le tonalità pastello tipiche dell’Angelico a San Marco, donano al dipinto una dimensione intima e soave.

È probabile che questa Annunciazione sia di poco posteriore a quella del corridoio, ma è sicuramente successiva alle tavole con analogo soggetto conservate rispettivamente al Museo del Prado di Madrid (1425-1426) e al Museo Diocesano di Cortona (1434-1436 ca.). Osservandole, si nota la progressiva evoluzione non solo dello stile del pittore – in parte condizionato anche dalla tecnica – ma anche della composizione.

L’ambientazione colma di arredi e rivestimenti sontuosi delle prime due Annunciazioni viene infatti sostituita nelle pitture parietali da spazi severi, quasi angusti. Scompare anche, dallo sfondo, la Cacciata dal Paradiso dei Progenitori. La scena dunque si libera di tutto ciò che non è funzionale alla diretta narrazione del fatto biblico, che appare così in tutta la sua eterna bellezza.
Intrisi di sincera e schietta spiritualità, gli affreschi dell’Angelico infondono ancora oggi quiete e armonia: uno spettacolo imperdibile per chiunque si rechi a Firenze.