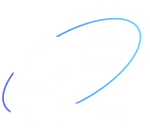Emblema di Firenze, la cupola della chiesa di Santa Maria del Fiore domina la città e, a seicento anni dalla sua costruzione, lascia ancora abbacinati per la sua insuperata imponenza. È infatti, ancora oggi, la più grande cupola in muratura mai realizzata, frutto della genialità di Filippo Brunelleschi, architetto visionario dal carattere fumantino. All’epoca della sua edificazione, pochi avrebbero scommesso sulla riuscita del progetto che – come racconta Vasari1 – rischiò più volte di naufragare…
Il problema della cupola
La costruzione della cattedrale iniziò alla fine del Duecento su progetto di Arnolfo di Cambio (1245-1302/1310 ca.). L’edificio fu ampliato a metà del Trecento, ma nel 1400 era ancora incompleto. A mancare era l’immensa cupola che avrebbe dovuto sormontare l’area presbiteriale a pianta ottagonale voluta da Arnolfo. Egli infatti era morto senza lasciare né il disegno né indicazioni scritte circa la copertura, sulla quale da tempo si scervellavano committenti, maestranze e cittadini.
Il problema non era cosa da poco: per chiuderla erano necessarie delle armature di sostegno in legno che difficilmente avrebbero retto il peso della cupola. Inoltre era impossibile provvedere all’approvvigionamento di tutto il legname necessario senza disboscare interi territori.
Come risolvere quindi la questione e dare finalmente compiutezza al duomo cittadino?
Sei interessato ad articoli come questo?
Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti e approfondimenti di BeCulture!
Brunelleschi, un “pazzo” con le idee chiare
Filippo Brunelleschi nasce nel 1377 a Firenze e si forma come orafo, distinguendosi subito per la vivacità intellettuale e il talento per l’architettura.
Amico fraterno di Donatello, parte con lui alla volta di Roma dove i due passano il tempo a studiare e copiare da vicino le antichità classiche per trarne insegnamento e ispirazione.
Filippo è fermamente intenzionato a trovare il modo per “voltare la cupola” (come scrive Vasari) di Santa Maria del Fiore.
Spinto da questo intimo proposito, si reca spesso al Pantheon e trascorre giorni a misurare e analizzare, incurante persino della fame e del sonno.
Convinto di aver trovato la soluzione giusta, rientra a Firenze. Ma guadagnarsi la fiducia degli Operai dell’Opera di Santa Maria del Fiore e dei Consoli dell’Arte della Lana – incaricati di portare a termine i lavori – non è facile e il suo approccio impulsivo rischia di mandare tutti i suoi sforzi in fumo.
L’adunata del 1420
L’occasione per emergere gli si presenta con l’adunata pubblica indetta nella primavera 1420 per valutare le proposte degli architetti locali e forestieri.
Le idee non mancano, anche delle più bizzarre: qualcuno arriva persino a suggerire di riempire la chiesa con una montagna di terra (da usare come sostegno durante la costruzione della cupola) e di nascondervi all’interno delle monete d’oro, lasciando poi ai cittadini ingolositi dalla ricompensa l’onere di smaltirla.
Dopo averli ascoltati tutti, Brunelleschi interviene: secondo lui è possibile compiere l’impresa senza terra, senza pilastri, persino senza armatura di supporto, semplicemente facendo una cupola doppia. Un’affermazione audace che fa scattare il riso del pubblico: a questa reazione, Filippo si inalbera e si infervora al punto da dover essere portato fuori di peso perché ritenuto pazzo.
La prova dell’uovo
Eppure, non passa molto tempo che gli stessi committenti tornano sui loro passi e coinvolgono di nuovo Filippo, che continuava a dirsi sicuro del fatto suo.
Questa volta però è lui a mettere gli altri in difficoltà: prende un uovo e sfida i colleghi architetti a farlo stare in piedi da solo su un piano. I tentativi sono, ovviamente, vani e quando gli viene chiesto di fare altrettanto, egli afferra l’uovo e, con delicatezza, ne rompe un’estremità, fermandolo dritto. Non servono più altre prove per dimostrare l’acume di Brunelleschi che, finalmente, ottiene l’incarico della cupola. Ma le noie per lui non sono ancora finite.
La rivalità con Ghiberti
Famosa quanto quella tra Leonardo e Michelangelo, l’ostilità tra Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti (1378-1455) risale al tempo del concorso per la decorazione della porta Est del Battistero di Firenze.
Immaginiamo dunque la rabbia che Filippo dovette provare nello scoprire che, data la sua presunta inesperienza, gli era stato affiancato proprio il suo acerrimo nemico: non soltanto non sarà l’unico capomastro, ma Ghiberti avrà la sua stessa paga (3 fiorini)!
Orgoglioso e impulsivo, è tentato di piantare tutti in asso e lasciare Firenze, ma gli amici Donatello e Luca della Robbia lo convincono a restare.
Così, nel 1420 viene posata la prima pietra della cupola sotto la direzione di Brunelleschi, il quale si occupa di tutto: inventa ponteggi, controlla i materiali, istruisce e corregge le maestranze e fa persino installare una cucina con zuppa e vino per gli operai all’interno del cantiere per ridurre al minimo le pause.
Sebbene sia preso anima e corpo dal progetto, che nel frattempo dura anni, proprio non riesce ad accettare la (rara e pressoché ininfluente) presenza di Ghiberti.
Deciso a liberarsi dell’odiato rivale, escogita un piano per escluderlo una volta per tutte e rifarsi della sconfitta di qualche tempo prima.
Giunti al punto più delicato della costruzione, Brunelleschi si finge malato e si chiude in casa per giorni. Le attività si bloccano e gli operai, preoccupati e incapaci di proseguire senza di lui, lo vanno a trovare. Qui Filippo lancia la prima stoccata contro Ghiberti, insinuando che, come risulta evidente, non sia in grado di portare a termine il lavoro, cosa che invece lui saprebbe fare benissimo anche in assenza del collega.
Tornato in cantiere, sferra il colpo definitivo e chiede a Lorenzo se preferisce occuparsi della progettazione delle impalcature o delle catene, necessarie per tenere insieme la cupola. Ghiberti sceglie queste ultime, ma i suoi modelli non reggono e Brunelleschi è ben contento di subentrare per correggerne il lavoro. È la prova che gli serve per dimostrare a tutti che l’unico vero capomastro è lui e, liberato finalmente il campo dall’intruso, riprende in mano le redini della fabbrica.
Nonostante questo, Ghiberti rimarrà sul libro paga della committenza per altri 3 anni, fino al 1426, secondo alcuni per magnanimità dello stesso Filippo.

La cupola del Brunelleschi: un modello di ingegneria e bellezza
I lavori proseguono per sedici anni e la cupola, alta 90 metri da terra alla chiave di volta, viene completata nel 1436.
La soluzione progettata da Brunelleschi – in pietra e mattoni – si basa su un sistema autoportante detto “spinapesce” che non prevede armature lignee di supporto e che verrà utilizzato anche in molte altre cupole successive.
La base ottagonale viene quindi voltata da due calotte ogivali, una interna e una esterna, collegate tra loro e composte da otto “vele”. Quelle esterne sono segnate dai costoloni in marmo bianco, divenuti ormai iconici, che convergono verso l’oculo in alto, dove sorge la lanterna di 21 metri sormontata dalla palla d’oro del Verrocchio.
Nell’intercapedine tra i due gusci si sviluppa il percorso di 463 gradini che consente ancora oggi di raggiungere la sommità e godere della vista mozzafiato sulla città.
Brunelleschi muore nel 1446, prima di poter vedere la cupola completamente terminata: la lanterna, realizzata secondo il suo progetto, venne conclusa circa vent’anni dopo.
“E si può dir certo che gli antichi non andorono mai tanto alto con le lor fabbriche nè si messono a un risico tanto grande che eglino volessino combattere col cielo; come par veramente che ella combatta: veggendosi ella estollere in tant’altezza, che i monti intorno a Fiorenza paiono simili a lei. E, nel vero, pare che il cielo ne abbia invidia, poi che di continuo le saette tutto il giorno la percuotono”. Così scrive Vasari a proposito della cupola e, pur nell’enfasi della narrazione, racconta qualcosa di vero.
Un’ultima curiosità infatti merita di essere menzionata e riguarda proprio i fenomeni atmosferici. Il 5 aprile 1492 un fulmine colpì la lanterna distruggendola in gran parte: un evento che fu letto come presagio della morte di Lorenzo il Magnifico, che avvenne solo tre giorni dopo. L’episodio si ripetè nel 1601, causando la caduta della sfera d’oro che, con i suoi 19 quintali di peso, danneggiò nuovamente la lanterna. Ancora oggi una lastra circolare in marmo bianco sul pavimento della piazza segna il punto in cui cadde la palla. Prima di rimetterla al suo posto, il granduca Ferdinando II fece inserire alcune reliquie al suo interno sperando nella protezione divina.
Non sappiamo se fu davvero questo a tutelare la cupola del Brunelleschi da lì in avanti. Comunque sia, rimase intatta. Svettando maestosa e bellissima sulla città, accoglie tuttora fiorentini e visitatori, e rende omaggio all’ingegno e alla caparbietà del suo unico brillante “inventore”.
1 Artista, architetto e uomo di lettere alla corte dei Medici, Giorgio Vasari (1511-1574), fu anche autore de Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri (edito nel 1550 e nel 1568, con aggiunte), opera fondamentale per la storiografia artistica italiana.