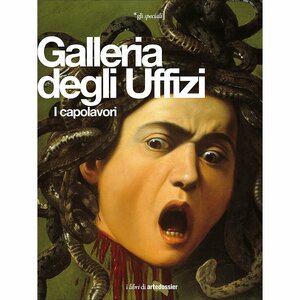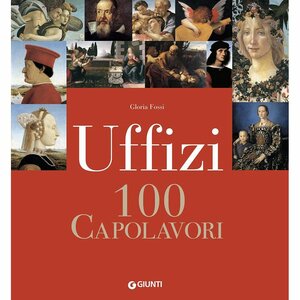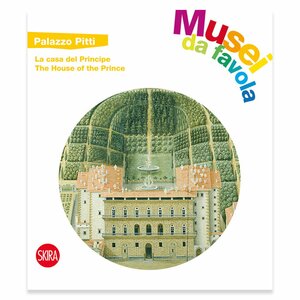Home / Esperienza / Bronzino
Bronzino

Tra i massimi esponenti del Manierismo fiorentino, Bronzino lavora al servizio della corte medicea e di altre importanti casate locali. Con la sua pittura preziosa, nitida, delicata pone le fondamenta per la ritrattistica moderna.
Le origini e la formazione
Agnolo di Cosimo di Mariano nasce nel 1503 a Monticelli, vicino a Firenze. Il soprannome con il quale oggi è conosciuto, il Bronzino, è forse dovuto al colore dei suoi capelli, simile al bronzo. Il pittore trascorre quasi tutta la sua vita a Firenze: è qui che si forma, lavora e muore. Figlio di un macellaio, quindi membro della piccolissima borghesia cittadina, si dedica fin da giovane allo studio della pittura.
Apprendista nella bottega di Raffaellino del Garbo, pittore erede della tradizione quattrocentesca di Filippo Lippi e del Ghirlandaio, a soli quindici anni entra nella bottega del Pontormo, artista già affermato e destinatario di importanti incarichi nella Firenze medicea.
Il rapporto tra maestro e apprendista evolve ben presto in una collaborazione attiva, diventando con gli anni un’intima amicizia. Accanto al Pontormo, tra il 1524 e il 1525, il Bronzino lavora agli affreschi della cappella Capponi nella chiesa di Santa Felicita, dipingendo i quattro medaglioni agli angoli della struttura architettonica progettata dal Brunelleschi (1377-1446). È con quest’opera che si presenta ufficialmente all’élite fiorentina e inizia a ricevere incarichi propri.
Il ritorno dei Medici e l’inizio della carriera come pittore di corte
Nel 1530 la Repubblica fiorentina cade. In un clima di grande incertezza e paura, i Medici riescono a rientrare in città anche grazie all’aiuto delle truppe dell’imperatore Carlo V (1500-1558). Ritornata al potere, la famiglia avvia un’intensa campagna di mecenatismo.
Tra tutti, il più grande promotore delle arti del neonato Ducato di Firenze, poi esteso a Granducato di Toscana, è Cosimo I insieme alla moglie Eleonora di Toledo. Grazie anche all’operato di Giorgio Vasari – artista, architetto e primo storico dell’arte – il granduca riuscirà a costruire un’immagine così raffinata e sofisticata della sua corte che la sua fama si estenderà in tutta Europa.
È in questo contesto che Bronzino riesce a rendersi indipendente dal Pontormo e a diventare ritrattista ufficiale dei Medici.
Per Cosimo I, appassionato di miti ed enigmi, il pittore realizza molti affreschi e dipinti a tema pagano, caricando ogni opera di profondi significati nascosti. Esemplare è il Ritratto di Cosimo I come Orfeo (1537-1539) oggi conservato al Philadelphia Museum of Art.
Il duca è raffigurato nei panni del musicista e poeta del mito, dopo che ha placato Cerbero, il cane guardiano dell’Ade, per riportare in vita la sua amata Euridice. Un dipinto enigmatico, in cui la nudità e la posa evocativa del giovane hanno lasciato ampio spazio all’interpretazione. Potrebbe trattarsi di un riferimento all’età di pace che la nuova generazione dei Medici aspirava a inaugurare, o di una celebrazione del ruolo di Cosimo come mecenate delle arti e delle lettere, o di un omaggio al suo matrimonio con Eleonora di Toledo nel 1539.
Ma se i soggetti allegorici sono spesso difficili da decifrare, con colori a volte innaturali – quasi capricci pittorici – come nella spettacolare Allegoria del trionfo di Venere (1540-1545, Londra, National Gallery), i suoi ritratti sono invece sempre più vicini al vero.
Intorno agli anni Quaranta, in concomitanza con le grandi commissioni medicee, Bronzino vira verso una rappresentazione iperrealistica della realtà, quasi la volesse immobilizzare, cristallizzandola in dipinti estremamente particolareggiati.
Tra le opere più famose di questo periodo: il Ritratto di Bia de’ Medici (1542 ca.), il celeberrimo Eleonora di Toledo col figlio Giovanni (1544-1545 ca.), il Ritratto di Cosimo I de’ Medici in armatura e il Ritratto di Maria de’ Medici (1551), tutti conservati alla Galleria degli Uffizi.
Uno stile unico, funzionale alla politica dei Medici
In questi anni Bronzino riceve l’incarico di ammodernare Palazzo della Signoria (l’attuale Palazzo Vecchio) scelto come dimora da Cosimo e dalla consorte Eleonora, e proprio per lei decora la Cappella privata, suscitando l’ammirazione dei suoi contemporanei.
La pala d’altare centrale con la Deposizione di Cristo, ha un tale realismo, una tale delicatezza e una così forte carica emotiva che il cancelliere dell’imperatore Carlo V in visita a Firenze, al vederla, ne rimane folgorato. Da buon politico e diplomatico quale è, Cosimo I decide di fargliene dono e chiede al Bronzino di realizzarne una copia identica, ancora oggi presente nella cappella. Oltre a numerosi personaggi dell’epoca, l’artista inserisce anche se stesso nella scena, insieme al suo maestro Pontormo e al suo allievo prediletto, Alessandro Allori.
L’attenzione ai dettagli dei volti, delle vesti, dei tessuti, degli accessori è quasi maniacale ed è nota la cura che il pittore riserva alla rappresentazione dei gioielli delle dame che ritrae.
La resa naturalistica della fisionomia diviene per lui così fondamentale che arriva a realizzare il Ritratto di Bia de’ Medici dopo la morte della bambina (deceduta a soli cinque anni) basandosi su una maschera mortuaria in gesso.
Secondo Giorgio Vasari, Bianca – detta Bia – era la «fanciulletta e figliola naturale del Granduca» Cosimo I, nata prima del matrimonio con Eleonora di Toledo. Nonostante questo, pare che la granduchessa fosse molto affezionata alla piccola e se ne occupava con molto amore. Durante un viaggio con il padre, però, Bianca si ammala improvvisamente e muore nel giro di poche settimane. Il ritratto postumo sarebbe quindi un omaggio voluto dall’addoloratissimo duca per l’amata figlia.
Il grande successo riscosso da Bronzino in questi anni è probabilmente legato anche al suo stile, che ben si sposa con gli ideali della restaurata dinastia medicea e con gli obiettivi di Cosimo I: definizione e idealizzazione dello status sociale, intellettuale e psicologico dei personaggi ritratti, e celebrazione dell’assolutismo del protocollo di corte. Uno stile elegante, dettagliato, riconoscibile che entra di diritto nella corrente del Manierismo.
Evidenti sono infatti gli influssi di Michelangelo e Raffaello nei volti e nella scelta dei colori: “dipingere alla maniera di” Leonardo, Michelangelo e Raffaello è proprio la caratteristica della prima Maniera.
La disputa sulla superiorità delle arti: il Nano Morgante
Coinvolto nel dibattito artistico noto come “paragone” sul confronto tra pittura e scultura, Bronzino realizza un’opera che provoca scalpore ma anche ammirato stupore: il Ritratto del Nano Morgante (1553 ca.), oggi alla Galleria Palatina di Palazzo Pitti. Quest’opera raffigura il famoso nano di corte, Braccio di Bartolo soprannominato sarcasticamente Morgante, completamente nudo. La particolarità del quadro non è tanto il soggetto, quanto il fatto di essere dipinto sia sul fronte che sul retro. Mostrando entrambi i lati dello stesso personaggio contemporaneamente, l’artista intende affermare la superiorità della pittura e mette a tacere coloro che vedevano nella bidimensionalità il suo limite maggiore.
Non solo, raffigurando il prima e il dopo la battuta di caccia, Bronzino aggiunge l’elemento temporale, impossibile da immortalare in scultura: il primato dell’arte figurativa è assoluto.
Gli ultimi anni
Bronzino lavora per la famiglia Medici durante tutta la sua vita adulta e, alla morte del Pontormo, termina i lavori lasciati incompiuti dal maestro.
Con gli anni diventa una figura di riferimento per il panorama culturale cittadino, tanto che nel 1563 fonda l’Accademia del disegno di Firenze, importante istituzione artistica già voluta da Michelangelo.
Quasi dieci anni dopo, il 23 novembre 1572 muore, all’età di sessantanove anni, nella casa di Alessandro Allori, con il quale da tempo convive. Il suo epitaffio è stato scritto, appunto, dall’Allori e recita così: «Non muore chi vive come il Bronzino visse: | L’alma è in ciel, qui son l’ossa, è il nome in terra | Illustre, ov’ei cantò, dipinse e scrisse».
Foto di copertina: Ritratto di Eleonora di Toledo con il figlio Giovanni, 1544–1545, Agnolo Bronzino, Galleria degli Uffizi, Firenze
Firenze, 1503 – Firenze, 1572
Pittura
Gli Uffizi
Acquista il bigliettoPalazzo Pitti
Acquista il bigliettoGalleria dell'Accademia
Acquista il bigliettoProdotti correlati
Musei correlati
A partire da €16,00
In origine residenza del ricco banchiere fiorentino Luca Pitti, questo magnifico palazzo viene acquistato nel 1550 dal Granduca Cosimo I de’ Medici il quale vi stabilisce la sua corte assieme alla moglie Eleonora di Toledo. Dopo due secoli, dal 1737, la reggia sarà la dimora della famiglia Lorena, succeduta ai Medici nel Granducato, ed in seguito dei Savoia durante i cinque anni in cui Firenze sarà capitale d’Italia.
Tempo medio di percorrenza:
2 ore
A partire da €12,00
La nascita della Galleria risale al 1784, quando il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo riorganizza l’antica Accademia delle Arti del Disegno, fondata nel 1563 da Cosimo I de’ Medici, nella moderna Accademia di Belle Arti. La nuova istituzione doveva ospitare una raccolta di dipinti antichi, moderni e di sculture al fine di facilitare la conoscenza e lo studio ai giovani allievi dell’Accademia.
Tempo medio di percorrenza:
1-2 ore