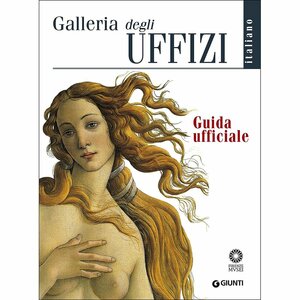Rinominato Museo Galileo nel 2010, lo storico Istituto di Storia delle Scienze dell’Università di Firenze è dedicato alle testimonianze materiali della scienza italiana ed è stato il primo del suo genere in Italia. Nella collezione – tra le più importanti al mondo – si trovano anche strumenti posseduti e ideati da Galileo Galilei: il celebre fisico e astronomo che, all’inizio del Seicento, sostenne la teoria copernicana eliocentrica in opposizione alla visione geocentrica della Chiesa Cattolica. Accusato di eresia, Galilei fu costretto ad abiurare ma le sue scoperte sono state successivamente confermate e oggi, nel Museo a lui intitolato, possiamo osservare da vicino alcuni degli oggetti che hanno contribuito alla scienza moderna.
Galileo Galilei, uomo di scienza e di cultura
Galileo Galilei nasce a Pisa nel 1564 e, dopo pochi anni, la famiglia si trasferisce a Firenze. Qui studia alla Facoltà delle Arti ma ben presto si appassiona di geometria e matematica, tanto da ottenere, nel 1592, la cattedra di matematica all’Università di Padova, dove insegna per quasi vent’anni. Un periodo piuttosto vivace, sul piano scientifico e personale: nascono in terra veneta tutti e tre i suoi figli, l’amatissima Virginia (1600-1634), Livia (1601-1659) e Vincenzo (1606-1649); realizza il compasso geometrico e militare e, nel 1610, dà alle stampe il Sidereus Nuncius (“Messaggero celeste”) dedicandolo al granduca di Toscana, Cosimo II de’ Medici (1590-1621).
Nello scritto, Galileo espone le sue osservazioni astronomiche – condotte per mezzo del cannocchiale – a favore della tesi copernicana. Secondo Copernico (1473-1543), il Sole occupa la posizione centrale e non la Terra: una teoria che oggi sappiamo essere vera, ma che allora contrastava apertamente con la visione geocentrica della Chiesa Cattolica e ne minacciava i fondamenti (la centralità e immobilità della Terra è sostenuta infatti dalle Sacre Scritture). Le reazioni del mondo eccelsiastico non tardano ad arrivare: gli scritti di Copernico vengono parzialmente censurati e Galileo viene invitato a non sostenerne la tesi.
Dopo un decennio di relativa tranquillità, lo scienziato torna però sui suoi passi e afferma nuovamente l’eliocentrismo nel Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (1632). Richiamato a Roma davanti al Tribunale dell’Inquisizione, l’anno successivo Galileo subisce un duro processo e viene costretto a rinnegare la sua posizione.
Fisico, astronomo ma anche filosofo e scrittore, Galileo muore nella sua casa di Arcetri, sui colli di Firenze, nel gennaio del 1642 lasciando strumenti, scritti, scoperte scientifiche e un metodo di lavoro (il famoso metodo sperimentale) fondamentale per lo sviluppo della ricerca moderna.

Il Museo Galileo e le sue collezioni
Il Museo Galileo occupa per intero Palazzo Castellani, antico edificio noto fin dai tempi di Dante. Aperto al pubblico nel 1930 come Istituto e Museo di Storia della Scienza sotto la direzione lungimirante di Andrea Corsini, oggi conserva oltre mille strumenti del patrimonio mediceo e lorenese.
Una raccolta imponente, che conferma l’interesse delle due casate per la promozione e la valorizzazione delle scienze. Prima di approdare alla sede attuale, infatti, la collezione era stata allestita e trasferita dai rappresentati delle due famiglie in vari luoghi simbolo: dal Guardaroba di Palazzo Vecchio, allo “Stanzino delle Matematiche” della Galleria degli Uffizi, poi a Palazzo Pitti presso l’Accademia del Ciment fino al Regio Museo di Fisica e Storia Naturale a Palazzo Torrigiani (oggi Museo La Specola). È qui che, nel 1841, il granduca Leopoldo II (1797-1870) fa costruire la Tribuna Galileo per ospitare il ritratto dello scienziato e soprattutto i suoi famosi strumenti.
Strumenti galileiani e cimeli da vedere
Il percorso di visita si snoda per diciotto sale tematiche che espongono numerosi congegni e apparati sperimentali secondo diversi punti di vista: la rappresentazione del mondo, la guerra, l’astronomia e il tempo, la scienza del mare, i nuovi mondi di Galileo e molto altro ancora. Nelle tre sale interattive al piano terra è inoltre possibile esplorare – in modo analogico e virtuale – le scoperte e gli strumenti galileiani.
Questi sono tuttora visibili nel Museo insieme agli altri: ecco alcuni degli oggetti più rari, significativi e curiosi dell’intera mostra.

Il compasso geometrico e militare
Nella Sala VII, cuore del Museo, si trova uno dei compassi costruiti da Galileo a partire dal 1597: probabilmente proprio quello donato dallo scienziato al granduca Cosimo II insieme al suo Le operazioni del compasso geometrico et militare, del 1606. A differenza del compasso comune, questo dispositivo non serve per disegnare ma per effettuare operazioni geometriche e aritmetiche complesse. Realizzato in ottone, si compone di due bracci graduati e raccordati a un disco (detto nocella), da un quadrante semicircolare e da un cursore mobile, che consente di tenerlo in verticale.
Oltre all’oggetto in sé, è interessante sapere che il compasso è stato al centro di una diatriba tra il suo inventore e lo scienziato milanese Baldassarre Capra, che si era attribuito la paternità dell’invenzione e aveva accusato Galileo di plagio. Un’affermazione inaccettabile per il pisano che risponde con un’efficace e categorica Difesa dimostrando, senza ombra di dubbio, come stanno le cose.
I cannocchiali e la lente media
A proposito di attribuzioni sbagliate, spesso si tende a dare a Galileo il merito di aver ideato il cannocchiale. In realtà non è così, poiché esemplari olandesi circolavano già all’inizio del Seicento. Tuttavia è vero che l’italiano ha portato numerose innovazioni allo strumento aumentando notevolmente il potere d’ingrandimento e aggiungendo accessori che consentivano non solo l’osservazione ma anche la misurazione dei fenomeni astronomici. Dopo averlo presentato al Senato veneziano come dispositivo militare per individuare imbarcazioni molto lontane, Galileo è il primo a puntarlo verso l’alto, per esplorare la volta celeste.
Proprio per la sua capacità di guardare a lunga distanza, nel 1611 il principe Federico Cesi, fondatore dell’Accademia dei Lincei, propone di chiamare lo strumento galileiano “telescopio”, dall’unione delle parole greche tele (lontano) e scopeo (vedo).
Il Museo conserva ben due cannocchiali originali dello scienziato, gli unici pervenuti sino ad oggi: uno in legno, carta e rame e l’altro di legno e pelle. Non solo, qui è esposta anche la lente obiettiva del cannocchiale con cui, tra il 1609 e il 1610, Galileo scopre i satelliti di Giove (chiamati dallo scienziato Medicea Sidera, con una dedica esplicita ai regnanti toscani). Donata al granduca Cosimo II, si è rotta accidentalmente, come si vede tuttora. Un episodio che non ne scalfisce il valore, sottolineato anche dalla bella cornice in ebano risalente al 1677, opera di Vittorio Crosten su commissione dai Medici.

Iconografia e reliquie: il busto e il dito medio
Compasso e cannocchiale sono gli strumenti che hanno contribuito maggiormente alla notorietà di Galileo e sono proprio gli stessi con i quali è ritratto nel busto di marmo che accoglie i visitatori nella settima sala. L’opera, richiesta da Cosimo III e realizzata nel 1674 da Carlo Marcellini, raffigura lo scienziato con il volto barbuto leggermente ruotato verso destra, mentre stringe a sé i due iconici oggetti. Un’immagine, tra le altre presenti qui, che attesta il prestigio raggiunto dal pisano, elevato a eroe e martire della scienza.
Ulteriore conferma di questo status è un altro elemento, che non manca di stupire i visitatori.
In una piccola teca di vetro a coppa con coperchio e decorazioni in oro, sorretta da una base in alabastro incisa, è custodito il dito medio dello scienziato. Si tratta di una delle tre dita prelevate, insieme a un dente, dalle spoglie di Galileo da Anton Francesco Gori, nel marzo 1737, durante il trasferimento della salma dalla sepoltura originaria al sepolcro monumentale della Basilica di Santa Croce, a Firenze. L’iscrizione sulla base, redatta da Tommaso Perelli, elogia il valore del dito, “[…] onde la mano illustre / Del Ciel scorse segnando i spazi immensi, / E nuovi Astri additò […]”.
Sei interessato ad articoli come questo?
Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti e approfondimenti di BeCulture!

Oltre allo studio dell’Universo, a Galileo dobbiamo anche alcune ricerche essenziali sul moto naturale di caduta e sul campo magnetico, nonché contributi significativi per l’invenzione del microscopio e del moderno termometro. Tracce materiali di queste e altre scoperte sono visibili all’interno del Museo che porta il suo nome e che ti invitiamo a esplorare nella sua interezza.
Ognuna delle sale racconta infatti un pezzo importante non solo della storia della scienza ma anche della concezione del mondo e della società delle epoche passate. Come ad esempio la sala XI che ospita le macchine elettrostatiche al centro delle cosiddette “serate elettriche”: dimostrazioni spettacolari di scintille e altri fenomeni naturali pensate per intrattenere e stupire l’alta società settecentesca.
Il Museo Galileo offre un viaggio sorprendente tra scienza, invenzioni e curiosità, capace di meravigliare e incuriosire adulti e bambini.