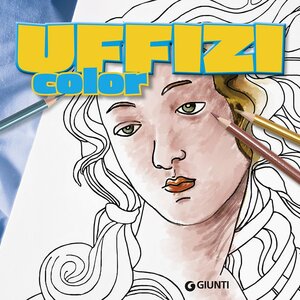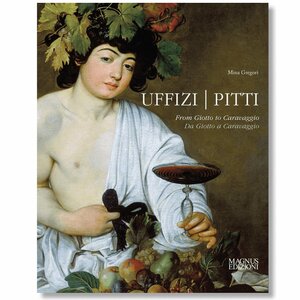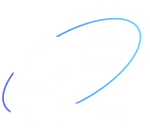Home / Esperienza / Giambologna
Giambologna

Scultore e architetto fiammingo simbolo del Manierismo a Firenze, riesce a coniugare la forza di Michelangelo con i raffinati virtuosismi dell’arte a lui contemporanea. Nato nel 1529 a Douai, nelle Fiandre, Giambologna si trasferisce nel capoluogo toscano a soli ventitré anni e qui passa gran parte della sua vita.
Uno scultore fiammingo in Italia
Non si hanno molte informazioni sull’infanzia del Giambologna, al secolo Jean de Boulogne, se non che il padre è notaio presso la cittadina di Douai. In questi anni le Fiandre sono soggette alla corona di Spagna, dominio diretto dell’imperatore Carlo V, che le aveva ereditate dalla nonna paterna Maria di Borgogna. Il sovrano ha un rapporto speciale con questo territorio, ma presto lascia la reggenza nelle mani dell’amata sorella Maria. Grazie a lei, i Paesi Bassi e le Fiandre vengono investiti da una ventata di rinnovamento culturale, influenzata profondamente dalla passione della Asburgo per l’arte classica italiana.
È in questo contesto frizzante, in un’epoca ormai prossima all’età moderna, che cresce e si forma il giovane Jean.
Il suo percorso artistico inizia nel 1540, ad appena undici anni, quando si reca ad Anversa per studiare presso lo scultore e architetto Jacques du Broeucq, maître-artiste dell’imperatore e noto anche al Vasari. Con il maestro lavora ad una cantoria a Mons e si presume abbia assistito alla ricostruzione del castello di Binche, residenza imperiale trasformata in un circolo di intellettuali e artisti da Maria d’Asburgo, intenzionata a rivaleggiare con l’allora rinomato castello francese di Fontainebleau.
È durante questo periodo che, con ogni probabilità, Jean entra in contatto con i modelli tardogotici e rinascimentali tipici dell’arte fiorentina. Dopotutto, lo stile di Du Broeucq si rifà chiaramente alle opere del Ghiberti e di Sansovino: opere che doveva aver ammirato in gioventù durante un soggiorno di studio in Italia.
Lo stesso farà, pochi anni dopo, il suo allievo: nel 1550, Giambologna parte alla volta di Roma per studiare le sculture di Michelangelo e dei suoi contemporanei. Il grande artista toscano è anziano ma ancora attivo e, nonostante non ci siano testimonianze sicure, sembra che i due abbiano modo di incontrarsi. Certo è che il giovane fiammingo si ferma nella Città Eterna almeno due anni, durante i quali realizza numerosi bozzetti in cera e terra, ispirandosi ai modelli antichi e alle opere dei maestri del Rinascimento. Qui entra in contatto con gli scultori Willem Tetrode, suo connazionale, e Guglielmo della Porta.
La grande stima per il Buonarroti lo segna nel profondo e lo influenzerà per tutta la vita.
Il primo soggiorno a Firenze e il debutto alla corte dei Medici
A ventitré anni Jean si trasferisce a Firenze. Sotto la protezione del ricco collezionista Bernardo Vecchietti, esponente di uno dei più antichi e potenti casati della città, si occupa dell’ammodernamento dello storico palazzo di famiglia e di diverse sculture, oggi perdute.
È proprio tramite le conoscenze di Bernardo che il Giambologna entra in contatto con la corte medicea, dapprima con il rampollo Francesco I, poi anche con il granduca Cosimo I e sua moglie Eleonora da Toledo.
Eppure, durante questi primi anni, deve accontentarsi di commissioni minori come lo Stemma Mediceo per il Palagio di Parte Guelfa restaurato dal Vasari e il Bacco in bronzo (1560-1565), oggi al Museo Nazionale del Bargello. Quest’ultimo, in particolare, testimonia l’aperta ammirazione di Giambologna per la celebrità di allora, Benvenuto Cellini, che pochi anni prima aveva svelato il suo meraviglioso Perseo con la testa di Medusa (1545-1554, Firenze, Museo Nazionale del Bargello).
È proprio il confronto con i giganti a lui vicini che costringe Giambologna a rimanere in disparte: i due granduchi hanno già una nutrita cerchia di artisti prediletti tra i quali Baccio Bandinelli, Bartolomeo Ammannati e, appunto, il Cellini ed entrare a farne parte non è impresa semplice.
Ma demordere non è nella sua natura e così, poco dopo, si iscrive al concorso per realizzare la Fontana del Nettuno di Piazza della Signoria. Oggi sappiamo che la vittoria – assegnata all’Ammannati – non era il suo vero obiettivo: Giambologna partecipa per mostrare al pubblico il suo formidabile talento. Una mossa astuta che gli apre la strada per nuovi progetti.
Le prime grandi commissioni: il Sansone e il Nettuno di Bologna
Dopo essersi esposto con successo durante il concorso fiorentino, Giambologna riceve l’incarico dal principe Francesco di una statua monumentale di Sansone e un Filisteo, oggi conservata al Victoria & Albert Museum di Londra. Terminato nel 1562 circa, questo gruppo scultoreo in marmo rivela la grande maestria del giovane artista e la sua predilezione per opere fruibili da più lati, senza un punto di vista privilegiato. Il dinamismo dei corpi, le linee curve e spiraleggianti, la carica emotiva della scena distingueranno la sua produzione anche nella maturità e fanno delle sue sculture veri e propri capolavori manieristi.
Nello stesso anno inizia a lavorare alle dipendenze del granducato, che lo impegna in diverse committenze per manifestazioni pubbliche.
Lenta ma inarrestabile, la carriera del Giambologna è ormai avviata. Lo conferma il fatto che, a distanza di pochi mesi, viene convocato a Bologna per realizzare un’imponente statua del Nettuno destinata alla fontana dell’omonima Piazza cittadina. L’opera – completata nel 1566 e tuttora visibile – si inseriva nell’ampio progetto di ristrutturazione voluto dal papato per la città emiliana, capitale settentrionale dello stato pontificio.
Il rientro a Firenze: la Fontana dell’Oceano e l’Appennino
Consolidata la propria fama anche agli occhi di un committente d’eccezione come Papa Pio IV, Giambologna rientra a Firenze dove lavora a diversi progetti per il granduca e la sua famiglia. Tra i più affascinanti, impossibile non citare la Venere Anadiomene (1572) per il Giardino della Villa di Castello. Collocata sulla sommità della Fontana del Labirinto progettata dal Tribolo per lo splendido parco, questa Afrodite nascente immortalata nell’atto di strizzarsi i capelli, fu ben presto scelta come allegoria della città di Firenze.
Sempre a completamento del lavoro del Tribolo, lo scultore realizza anche la Fontana dell’Oceano (1567-1576, Firenze, Museo Nazionale del Bargello) per il Giardino di Boboli. Al centro della composizione svetta la maestosa figura di Nettuno su una vasca in granito, procurata qualche tempo prima dal granduca Cosimo I. Tutte attorno, le tre figure del Nilo, del Gange e dell’Eufrate riversano le proprie acque ai piedi del dio. Con la sua articolata composizione, i bassorilievi e i giochi d’acqua, l’Oceano è chiara espressione del gusto manierista sempre più diffuso nella Firenze dell’epoca.
A questa felice e prolifica stagione risalgono anche la Venere al bagno (1572-1584), ancora oggi presente all’interno della Grotta del Buontalenti nel Giardino di Boboli, e il mastodontico Appennino per la Villa di Pratolino. Un vero e proprio gigante che simboleggia l’omonima catena montuosa che separa la Toscana dall’Emilia-Romagna. Accovacciato su un laghetto artificiale e ricoperto di concrezioni che imitano la neve sui picchi delle montagne, il colosso cela al suo interno numerose stanze segrete, tra le quali spicca quella affrescata dal pittore di corte Jacopo Ligozzi, contenente una fontana ottagonale. La progettazione di questa meraviglia manierista comprende non solo un complesso insieme di giochi d’acqua e di figure tratte dalle Metamorfosi di Ovidio, ma anche una serie di condotti nascosti che permettevano all’Appennino di piangere e trasudare acqua dalla testa lungo tutta la superficie di pietra. Questo curioso meccanismo faceva sì che il gigante si rivestisse di ghiaccio durante gli inverni più rigidi, così come gli Appennini – dei quali porta il nome – sono ricoperti di neve.
La maturità e l’immortalità artistica
Scultore ormai affermato e molto apprezzato dal granducato di Toscana, nella seconda metà del secolo Giambologna raggiunge l’apice della fama, complice anche la progressiva scomparsa dei grandi della generazione precedente, che poco spazio gli avevano concesso in gioventù.
Straordinaria è la sua produzione di bronzetti, tra i quali spicca il Mercurio volante, realizzato intorno al 1580 e replicato in varie versioni successive. Oggi conservato al Bargello, questa figura danzante, dinamica e leggiadra, rappresenta il dio mentre è colto in un aggraziato slancio verso l’alto. Grazie alle numerose copie dello stesso Giambologna, il Mercurio ha contribuito molto alla diffusione del linguaggio manierista anche fuori dall’Italia, ammirato dai contemporanei in tutte le corti europee.
Il Ratto delle Sabine
Il coronamento assoluto della produzione del Giambologna avviene, sempre nello stesso anno, con la sua opera più famosa: il Ratto delle Sabine. Questo enorme gruppo scultoreo di oltre 4 metri di altezza, oggi esposto sotto la Loggia dei Lanzi a Firenze, raffigura una fanciulla sollevata violentemente da un giovane, ai cui piedi si divincola, impotente, un uomo più maturo. Il parallelismo con l’omonimo episodio della leggendaria fondazione di Roma (il rapimento delle donne Sabine da parte dei romani) sembra essere un’interpretazione successiva e non la fonte d’ispirazione iniziale del Giambologna.
Con quest’opera di rara audacia, l’artista vuole ribadire il suo talento, rompendo con la tradizione classica e superando persino l’inarrivabile Michelangelo.
Come già il Sansone, anche il Ratto delle Sabine è pensato per essere ammirato non solo frontalmente, ma da tutte le angolazioni. Erede delle teorie di Benvenuto Cellini (il quale affermava che ogni buona scultura dovesse avere otto vedute diverse), rappresenta una delle massime espressioni dell’arte italiana della seconda metà del Cinquecento, una vera e propria dichiarazione della maestria del suo creatore.
Jean de Boulogne muore nel 1608 nella Firenze che lo ha reso celebre, al termine di una carriera di successo come artista di corte. Le sue opere, eterne e universali, continuano a incantare generazioni di spettatori.
Foto di copertina: Ritratto di Giambologna, 1591, Hendrick Goltzius, Teylers Museum, Haarlem, Paesi Bassi
Douai, 1529 – Firenze, 1608
Pittura, scultura
Museo Nazionale del Bargello
Acquista il bigliettoGiardino di Boboli
Acquista il bigliettoGli Uffizi
Acquista il bigliettoProdotti correlati
Musei correlati
A partire da €9,00
L’antico Palazzo del Podestà di Firenze ospita oggi il Museo Nazionale del Bargello. Dedicato principalmente alla scultura, fa parte dei “Musei del Bargello” insieme alle Cappelle Medicee, ad Orsanmichele, al Palazzo Davanzati e a Casa Martelli.
Tempo medio di percorrenza:
1-2 ore